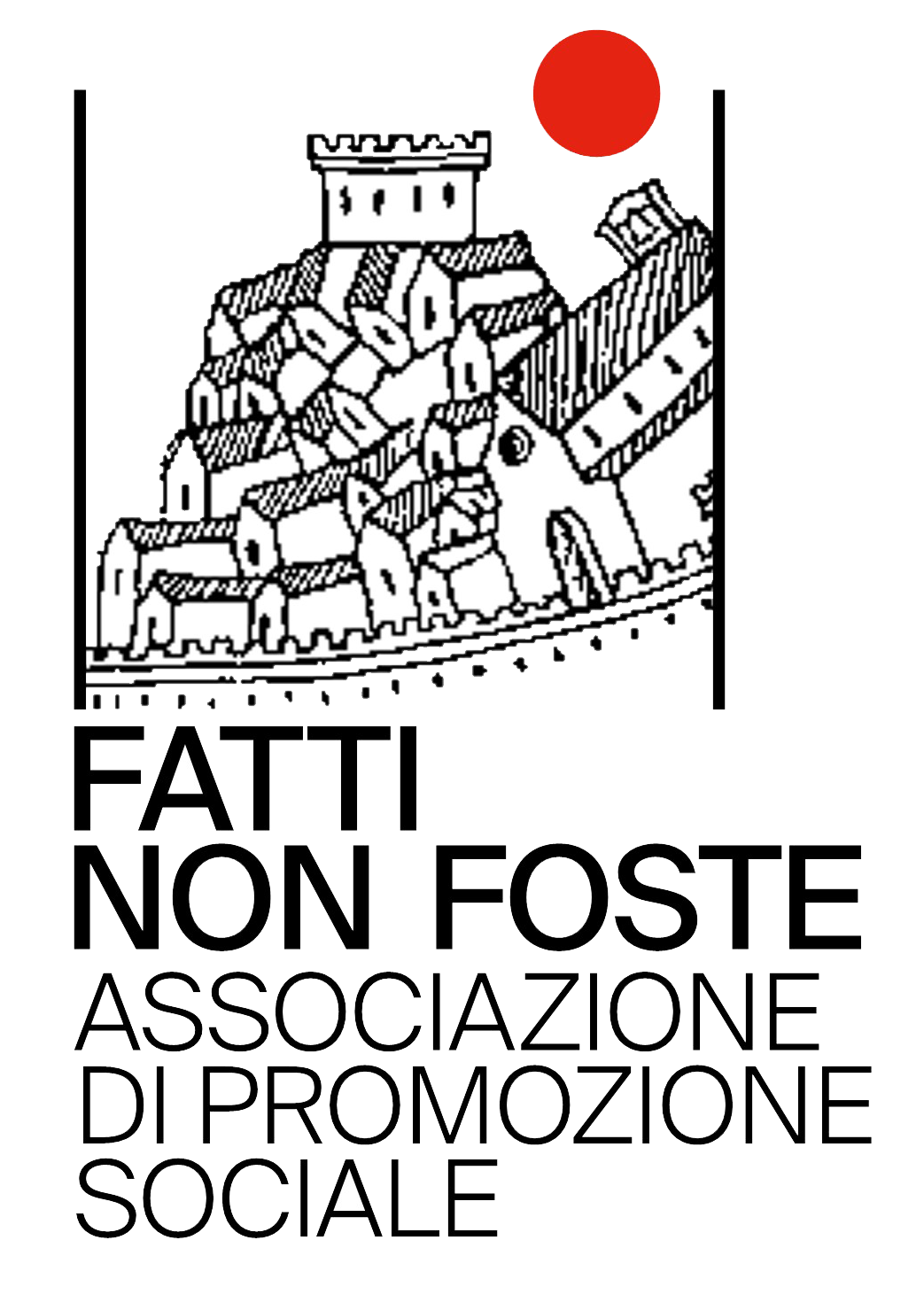Introduzione al libro “Schegge e trucioli” di Peppe Lomonaco a cura di Angelo Andriulli
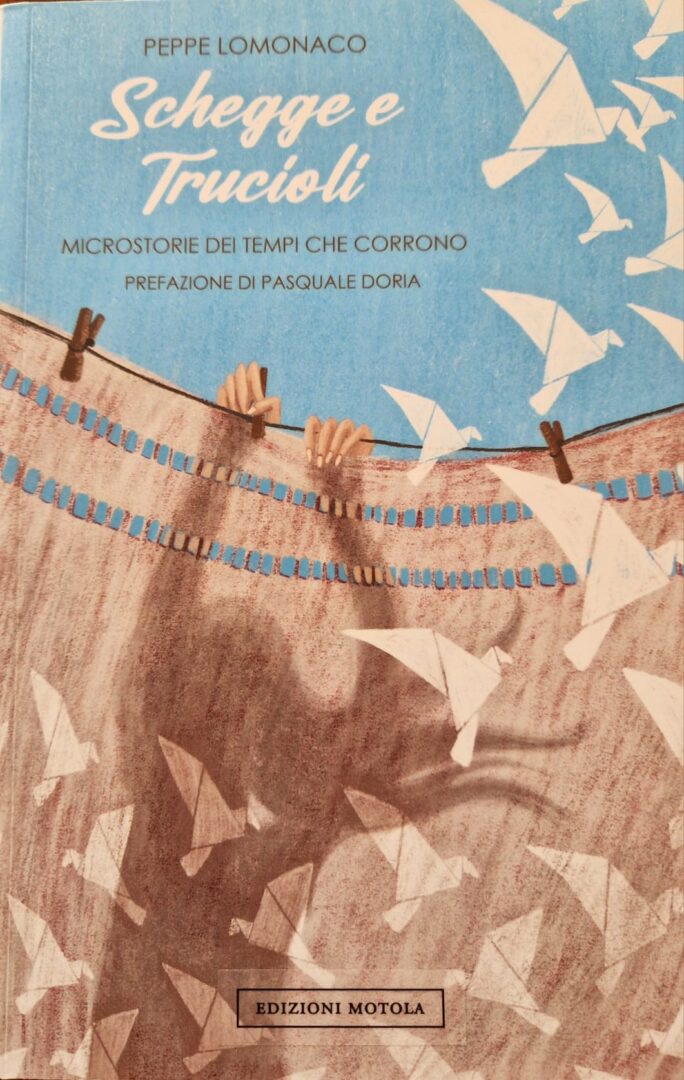
Ho avuto il privilegio di sentir raccontare in anteprima, dalla viva voce di Giuseppe (“Peppe” come tutti lo chiamano in paese) Lomonaco, le storie contenute in questa ultima sua fatica letteraria, a me anticipate durante le passeggiate mattutine, effettuate insieme negli ultimi due anni nella boscaglia perimetrale al paese, “La Difesa”. Camminando, camminando, ci scambiavamo impressioni, giudizi, confidenze e storielle, che hanno incrociato le rispettive esperienze personali e che animano le nostre memorie. In alcune di esse mi riconosco come colui che le ha presentate a Peppe, mentre per la maggior parte dei racconti compresi in questo volume gli sono grato per aver attinto alla quotidianità del paese, per essersi avvicinato al lento trascinarsi di passi e storie paesane snocciolate lungo le stradine medievali, allo sfottò amichevole con cui si intessono i discorsi degli anziani, seduti sulle panchine in piazza alla ricerca del sole o del riparo ombroso, a seconda del volgere delle stagioni. Nel riportare questo chiacchiericcio che potrebbe risultare vacuo, Peppe si accosta, come modello, alla grande letteratura delle “novelle” di boccaccesca o pirandelliana memoria. Ma quello che emerge dalla lettura del libro è sia lo sfondo sociale dal quale l’Autore ritaglia personaggi ed avvenimenti, sia la bonarietà dello scrivente nel delineare gli attori delle vicende stesse.
Le storie sono “brevi” e, forse, meriterebbero essere identificate come “storielle”, termine quest’ultimo non alludente ad una forma espressiva minore, ma ad un tratto distintivo della scrittura di Peppe sia per la soavità narrativa che stempera la drammaticità delle esperienze raccontate, e sia per una rapidità nella loro formulazione letteraria con un tratto rapido ed incalzante della narrazione. Non è raro ritrovare, come chiosa del racconto, un commento bonario, un sorriso di comprensione nei riguardi della vicenda raccontata. Anche quando il personaggio si tinge di aspetti negativi, riprovevoli socialmente, Peppe non lo addita a commiserazione, ma lo umanizza e lo assolve. Chiosando il contenuto di un cartello sulla porta di un locale materano e che recita “Il vino uccide, ma io lo perdono”, si potrebbe dire che Peppe tratteggia in modo simile i personaggi dei suoi racconti, sempre alla ricerca di un sorriso di comprensione e partecipazione.
Ma cosa racconta l’Autore? Le vicende presentate hanno un ambito cronologico ben definito, e che potremmo racchiudere nell’arco temporale, che parte dall’inizio degli anni ’50 per fermarsi alla fine degli anni ’80 del secolo scorso. In questo lasso temporale la stratificazione sociale in Montescaglioso ha visto operare e, di poi, dissolversi due categorie ben distinte: la gran massa del proletariato che racchiudeva il mondo contadino e le botteghe artigiane, e la classe borghese inglobante il ceto impiegatizio e proprietari terrieri, inferiore di consistenza numerica alla prima ma auto-definitasi superiore in considerazione, tale da richiedere il prefisso “don” al proprio nome e cognome. E’ la prima di queste due classi che Peppe frequenta e tratteggia, da cui ricava, per trasmissione orale diretta, le vicende che poi invera nella pagina scritta. Di questa classe, non più esistente nella sua composizione sociologica, o se pure esistente non più rubricabile sotto la voce “proletariato”, egli delinea vicende minime, umili e anche banali, ma significative per la comprensione della “fatica di vivere”. Del secondo strato sociale descrive l’autoreferenzialità, i piccoli soprusi derivanti dall’occupare una posizione di una minima autorità, le opportunità pelose nel far intendere, senza esplicitare, richieste di compensazione extra per un servizio dovuto, la grettezza mentale nel sopraffare il sottoposto o il cliente, unito all’ossequio sperticato del diretto superiore, oggetto di opportuna deferenza e sottomissione.
Attraverso queste “storielle” traspare un dato sociologico su quella che era la quotidianità del vivere a Montescaglioso nel ventennio considerato, una cittadina meridionale in cui la gente si industriava per campare tra ristrettezze economiche e scarsità di prospettive migliorative. Sebbene l’epoca, alla quale i fatti raccontati si riferiscono, sia distante cinquant’anni da quella che ci è dato vivere, la universalità del messaggio veicolato rende attualissima la lettura del libro, in quanto c’è sempre nella vita chi è costretto a chiedere, e chi approfitta della situazione. Tra queste pennellate di quotidianità vorrei segnalare la pietas nei riguardi di una nuova categoria che si è innestata di recente nella vita paesana, ritenuta ancora estranea dai nativi, ma a cui Peppe guarda con rispetto e partecipazione alla loro condizione: si legga il racconto “Badante” a pag. 208 dove, in 20 righe di testo, viene racchiusa tutta la vicenda umana di queste giovani donne: “sono la badante di chi è giunto al termine della sua corsa”. Pur parteggiando per i deboli posti nei gradini più bassi della considerazione, Peppe sa esser lieve anche per gli altri, tratteggiandoli con benevole ilarità ed ironia, senza mai trascendere nel sarcasmo o dileggio. Ma tale lievità e serenità nel giudizio, a ben vedere, forse, è ancora più grave, in quanto essa associa ad una descrizione di un evento, di per sé riprovevole, un carico di sberleffi.
Tuttavia, gli episodi raccontati, le vicende piccole e marginali descritte, i personaggi delineati non dipingono solamente l’atmosfera del vivere quotidiano in una piccola cittadina come Montescaglioso, ma attraverso questa si intravvede il modus vivendi che è proprio di tutto il nostro paese, dove il senso civico in senso lato è stato soppiantato dall’apparire, dove l’arbitrio ha oscurato la coscienza morale, la furbizia rifulge più che il rigore. E’ amaro constatare, dopo la lettura del libro, come a distanza di secoli da chi l’aveva per primo indicato, il fine giustifica ancora i mezzi per ottenerlo!
Un’ultima considerazione merita la forma letteraria della scrittura di Beppe. Scorrendo il libro, il purista letterario non mancherà di incappare in errori grammaticali, tali da far sorgere riserve sul valore accademico del volume edito. “Non sa scrivere in italiano” è la epigrafe, riferitami dall’Autore, con cui si è negato dignità di pubblicazione a qualche precedente suo lavoro. In effetti, i dettami della sintassi grammaticali vengono di frequente strapazzati nello scritto! Ma, a parere di chi scrive, il linguaggio di Peppe merita di essere preservato così come esso si palese nel testo. Mentre le regole grammaticali cristallizzano una lingua in criteri formali che la irrigidiscono nel tempo, il linguaggio parlato riferisce di una quotidianità del vivere e, in quanto tale, di per sè mutevole. “A me non mi piace ….” è un’espressione grammaticalmente scorretta, ma ormai di uso corrente. La forma espressiva di Peppe aderisce al parlare quotidiano. Essa riconosce nel dialetto montese la sua origine profonda. Ma, essendo quest’ultima forma espressiva quasi del tutto scomparsa nella parlata montese, soffocata dall’imperante italiano presente nei media cartacei e televisivi, il linguaggio di Peppe è un prezioso documento di quella che è ormai diventata la parlata montese odierna: nient’altro che un dialetto italianizzato. A Montescaglioso si parla così!